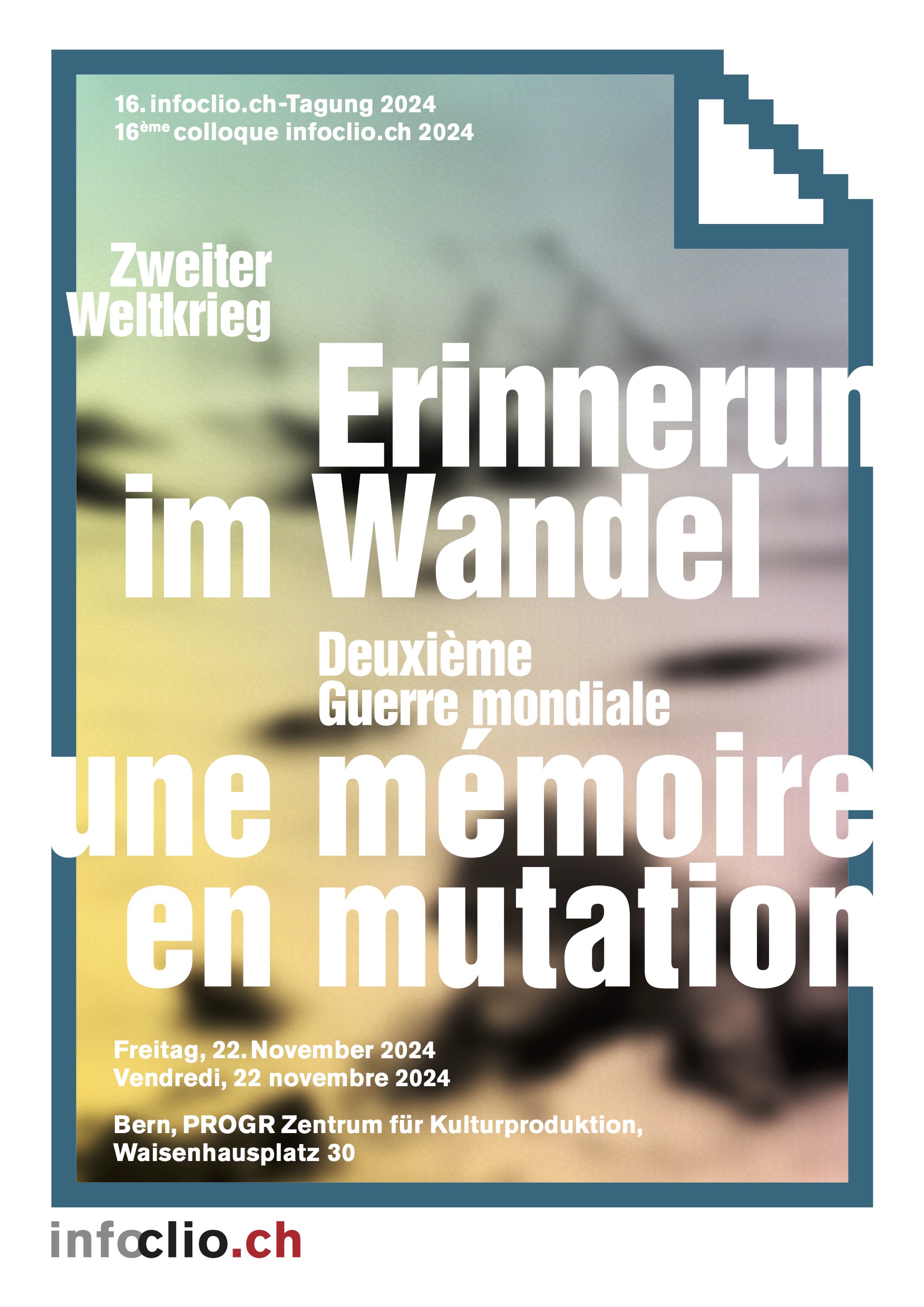Storie e memorie di frontiera: il confine italo-elvetico negli anni della dittatura fascista
Storia e memoria sembrano termini spesso conflittuali che faticano a trovare un punto di convergenza. «Il conflitto è quello antico e sempre nuovo – ha scritto Adriano Prosperi – tra storia come conoscenza accertata del passato e memoria come funzione psichica, dunque viva e palpitante ma nello stesso tempo finestra mentale più aperta all’errore e alla falsificazione»1. Come conciliare dunque la necessità del ricordo con la presa di coscienza del dimenticato? Il tema è avvincente, portato alla luce da Alberto Cavaglion in un recente volume in cui l’autore sottolinea come «i ricordi gravosi non vanno mai presi di punta, non li si impone per legge, non li si urla ad alta voce, ma vanno cercati nel cuore di una narrazione diagonale»2. L’invito sembra andare appunto verso una “memoria obliqua”, da coltivare nell’intimità, lontana dai condizionamenti e dagli ondeggiamenti della lotta politica, dove a prevalere non sia «la dinamica del viaggiatore distratto, ma la staticità del viaggiatore immobile»3. Sono “i tempi lunghi di un’attesa sulla soglia”, limite che è anche periferia – non soltanto metaforica – della storia, “luoghi del crimine organizzato”, “scenari di violenza urbana”, dove soltanto il necessario “tempo dell’attesa” può aiutare a rendere familiari quei paesaggi, depurandoli da pericolose contaminazioni.
Il confine italo-elvetico, fragile barriera tra fascismo e democrazia, “terra di frontiera” a cavallo tra due distinte entità politiche, è palcoscenico sul quale negli anni si sono coagulate tensioni frutto appunto di quegli incontri-scontri destinati a segnare la memoria pubblica, italiana ed elvetica. Da un lato l’incapacità svizzera a riconoscere sin dagli anni Venti i tratti salienti del nascente regime, dall’altro una certa abilità di quest’ultimo a infiltrarsi nel piccolo Stato attraverso pressioni frutto di dubbie politiche culturali, ma anche per una certa desistenza di Berna o dal consenso non troppo velato di alcuni ambienti federali. Un fragile equilibrio che, nel tempo, avrebbe giocato a favore della dittatura, “totalitarismo fuzzy” – come suggerito da Umberto Eco – «non ideologia monolitica, ma piuttosto un collage di diverse idee politiche e filosofiche»4. Un alveare di contraddizioni, frutto di quella “sgangheratezza politica e ideologica” che gli avrebbe permesso di mantenere un fragile equilibrio e, conseguentemente, rapportarsi a seconda delle convenienze contingenti, con uno Stato certamente liberale, ma che al fascismo avrebbe guardato – soprattutto nei primi tempi – con una certa indulgenza se non proprio benevolenza.
Benché i gravi avvenimenti italiani dell’autunno 1922 fossero passati in Svizzera quasi sottotraccia, scavalcati dai dibattiti sia per il rinnovo del Consiglio Nazionale, sia per l’approvazione in Ticino della nuova legge elettorale5, la tenace politica d’infiltrazione culturale fascista – soprattutto nella Svizzera italiana – inizia ad alimentare diffidenze e preoccupazioni6. Accentuate, sui confini, prima dai rafforzati controlli della nascente dittatura, poi, nel tempo, da una sua crescente violenza su quelle periferie dove l’intreccio tra fuoruscitismo politico ed emigrazione economica, finisce per svelare l’atavica e “fraterna passività” delle locali popolazioni, ben tratteggiata da Carlo Levi nel rapporto tra confinati e contadini negli anni Trenta7. Legame non religioso ma naturale, un “patire comune” – così evidenzia nel dopoguerra l’artista e narratore torinese – destinato a tradursi in una tacita alleanza frutto della mai risolta dualità tra Stato e regime che, di fatto mai composta, avrebbe esacerbato la fondante e distintiva aggressività della dittatura mussoliniana. Il cui abortito tentativo di creare una nazione-Stato, forte e compatta, si scaglia appunto contro quelle inermi popolazioni di frontiera, da sempre accusate di contrabbandi, smerci e favoreggiamento agli espatri clandestini.
Di fronte quindi a uno Stato incardinato sulla violenza sistematica, e una Confederazione in precario equilibrio nei suoi ondivaghi rapporti internazionali, la saldatura negli anni della Repubblica Sociale, quindi durante il biennio 1943-1945 – tragica e sanguinaria appendice di un fascismo agli sgoccioli – tra un’opposizione organizzata e un antifascismo spontaneo, avrebbe plasmato e dato rinnovato significato a quel tormentato confine, sollecitando il condiviso e unanime impegno nel rompere «l’eterno destino guelfo del popolo italiano»8. Per quest’ultimo è certamente l’uscita dal conformismo, ma non ancora l’assunzione di una matura consapevolezza politica che sola avrebbe potuto dare senso a un passato forgiato sulla labile memoria della frontiera, ventennale teatro dell’incontro-scontro tra dittatura e libertà9. Ecco allora il richiamo iniziale alla staticità del “viaggiatore immobile” di Cavaglion, capace appunto di una lunga “attesa sulla soglia” che gli permetta la necessaria riflessione a “decontaminare la memoria” per poi trasformarla in storia, da un lato per contribuire a scalfire l’attuale e ancora persistente «sottovalutazione del fascismo, da cui derivano la banalizzazione, le amnesie, le striscianti riabilitazioni»10, dall’altro nella consapevolezza che soltanto «una valutazione ferma e realistica del passato è uno dei modi migliori per formare un’identità nazionale convinta e convincente»11. Forse l’unico strumento utile per costruire e tramandare quella salda memoria di un passato che, proprio dalle periferie, ha conosciuto i più brutali e tragici risvolti.
1 A. Prosperi, Un tempo senza storia. La distruzione del passato, Einaudi, Torino 2021, p. 26.
2 A. Cavaglion, Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, sogni, Add Editore, Torino 2021, p. 61.
3 Ivi, p. 86.
4 U. Eco, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 25.
5 A titolo d’esempio si rimanda a L. Saltini, Il Canton Ticino negli anni del “Governo di Paese” (1922-1935), Guerini e Associati, Milano 2005.
6 P. Codiroli, L’ombra del duce. Lineamenti di politica culturale del fascismo nel Canton Ticino (1922-1943), Franco Angeli, Milano 1990.
7 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1990, p. 68.
8 M. Isnenghi, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo, Roma-Bari 2011, p. 554.
9 Sui rapporti di confine tra Italia e Svizzera durante i vent’anni di dittatura fascista, mi permetto di rimandare a F. Scomazzon, La linea sottile. Il fascismo, la Svizzera e la frontiera (1925-1945), Donzelli 2022.
10 A. De Bernardi, Fascismo e antifascismo. Storia, memoria e culture politiche, Donzelli, Roma 2018, p. 63.
11 P. Corner, Mussolini e il fascismo. Storia, memoria e amnesia, Viella, Roma 2022, p. 142.